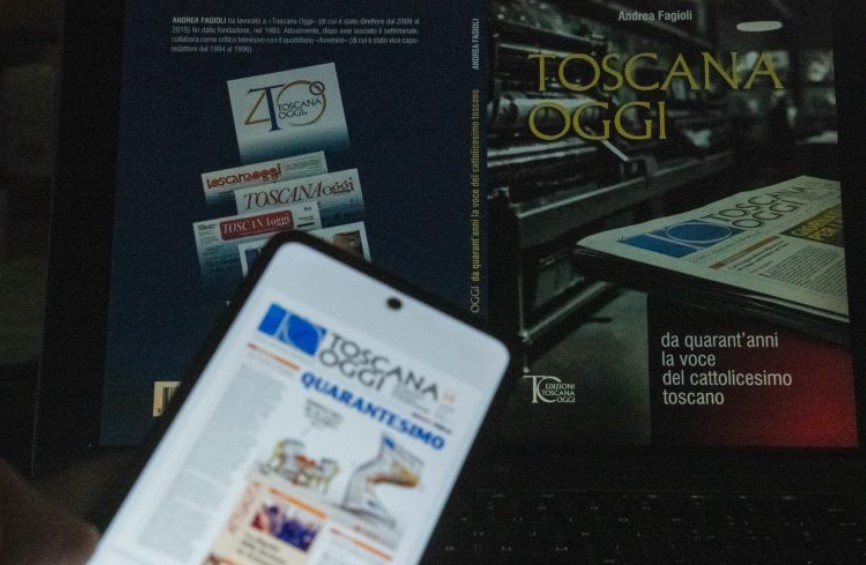Cultura & Società
Buon compleanno, Maestro Verdi!

Giuseppe Verdi, subito dopo il successo di Ernani, suo primo impegno con il Gran Teatro la Fenice di Venezia, firma un contratto con Alessandro Lanari per comporre un’opera da dare in uno teatri da lui gestiti. Nasce così un sodalizio che produrrà una prima assoluta al Teatro Argentina di Roma (I due Foscari, 1844) una alla Fenice (Attila, 1846) e una al Teatro della Pergola di Firenze (Macbeth,1847).
Il soggetto per Firenze fu discusso da Verdi insieme al poeta Andrea Maffei, che stava trascorrendo con lui un periodo di vacanza a Recoaro. La scelta era caduta su tre titoli: l’Avola,e Macbeth. L’opzione finale sarebbe dipesa soprattutto dalla composizione del cast di cantanti che l’impresario Lanari avrebbe avuto a disposizione.
La decisione di fare Macbeth fu determinata anche perché Verdi da anni ambiva a mettere in musica un dramma di Shakespeare. Egli già «meditava» sulle parti, vedeva il soprano Sophia Loewe come Lady (sostituita poi dalla Barbieri Nini) e il baritono Felice Varesi come Macbeth. In quel momento nella compagnia lanariana come tenore c’era Napoleone Moriani chiamato, per le sue capacità vocali, «il tenore della bella morte», che però non era all’altezza delle aspettative del Maestro. Pertanto Verdi, come ci informa Muzio, alla fine scelse di musicare il Macbeth perché «non abbisogna più di un tenore di grande forza». Così, in una lettera del 22 agosto 1846, Verdi scrive a Piave: « Forse forse, (ma silenzio!) faremo il Macbet. Se Lanari mi seconda lo faccio!». Due settimane dopo invia a Piave lo «schizzo» del Macbeth con le solite, ampie e puntigliose precisazioni: «questa tragedia è una delle più grandi creazioni umane! […] se noi non possiamo fare una gran cosa cerchiamo di fare una cosa almeno fuori del comune». Lo «schizzo» era la trama del dramma, in prosa, già tagliato scena per scena e pronto per essere «verseggiato». Verdi aveva già fatto la scelta (sicuramente guidato dal Maffei) di tutte le parti di sicuro effetto scenico. Continua il Maestro: «Lo schizzo è nétto: senza convenzione, senza stento, e breve. Ti raccomando i versi che essi pure siano brevi: quanto più saranno brevi e tanto più troverai effetto». Piave, come scrive l’Abbiati, non «sospettando le pedate [che poi avrà], manda avanti a tutta velocità l’orrenda sfaticata» e, in due settimane, invia al Maestro l’introduzione , la cavatina di Lady Macbeth e il duetto Macbeth e Banco. Ma per Verdi la poesia ha poca energia, le parole sono troppe e lo stile non abbastanza conciso; così gli raccomanda che: «prima d’ andare avanti fa in modo che io non abbia da credere questo lavoro buttato là tanto per finirlo come mi pare di vedere finora».
All’inizio di ottobre Verdi e Piave trascorrono qualche giorno a Como dove lavorano insieme sul primo atto ma, alla fine del mese, il secondo non è ancora finito. Scrive concitato Verdi a Piave: «Mi parli già del terzo atto? Ed il secondo è finito? Perché non lo mandi? […] Fai troppo presto e prevedo dei guai!», e poi rincalza: «Come si può in sì poco tempo [scrivere] un atto di quella sublimità come il 2° atto del Macbeth?». Nel postscriptum suggerisce a Piave la frase che la Lady dovrebbe dire nella scena del 2° atto, indicandogli anche le parole: «Oh Macbeth è necessario un altro delitto!», ed esprime la sua «desolazione» perché il librettista non sa cosa «far dire alle streghe quando Macbeth è svenuto […] Non c’è in Shaespeare? (sic!) Non c’è una frase che aiuti li Spiriti aerei a ridonare i sensi perduti? Oh povero me!!». Ma in dicembre le cose non erano molto cambiate. Oltretutto il poeta iniziava (forse per sfinimento) a controbattere le opinioni del maestro in merito agli «Spiriti aerei» e facendo trascurabili modifiche al coro degli stessi. Il 9 novembre da Milano Verdi scrive a Piave una missiva dal tono piuttosto seccato:« Mio bel Mona te la prendi comoda con questo Macbet!! […] mandami subito il secondo atto e studia subito il terzo! Hai capito?». E il 10 dicembre, ancora preoccupato di come Piave potesse verseggiare il quarto atto, adirato gli scrive: « Di qui in avanti daremo sempre ragione a Lei Sig. Poeta: sì sì hai ragione, hai ragione, hai ragione sempre sempre …». E il 22 incalza – in una lettera a Lanari – preoccupandosi della messa in scena dell’opera, con «preziose» indicazioni sul macchinismo e le fantasmagoria: «Guarda che l’ombra di Banco deve sortire sotterra», e rinforzando la richiesta con la giustificazione che tutti i suggerimenti gli erano venuti da Londra. Ma non mancavano rimbrotti anche per l’editore Ricordi al quale, il 29 dicembre, così scrive: «Approvo il contratto che hai fatto per l’Opera mia nuova Macbeth che andrà in scena nella prossima quaresima in Firenze, […] e do la mia adesione perché tu ne faccia uso, colla condizione però che tu non permetta la rappresentazione di questo Macbeth all’I. R. Teatro alla Scala. […] Non posso dimenticarmi del modo pessimo con cui sono stati messi in scena i Lombardi, Ernani, Due Foscari […] ti ripeto addunque che io non posso ne devo permettere la rappresentazione di questo Macbeth alla Scala, almeno fino a che le cose non sieno cambiate in meglio».
Riscontriamo che sul versante «poeta» c’è il vuoto di un mese nel carteggio tra Verdi e Piave, (dal 22 dicembre al 21 gennaio), il che rende difficile formulare qualsiasi ipotesi se non quella di un avvenuto cambiamento nel rapporto di lavoro tra i due. Infatti, nella lettera del 21 gennaio a Piave Verdi già menziona Maffei: «S. Andrea ha aiutato te e me: e me più ancora perché se devo parlarti francamente, io non avrei potuto metterli in musica […] Ora tutto e accomodato cambiando però quasi tutto». Dalla lettera si desume che il contributo dato dal Maffei riguardi gli ultimi due atti (il coro delle streghe del III atto e la scena del sonnambulismo) anche se nel libretto trovato alla Scala (copia manoscritta di Verdi) ci sono correzioni di mano del Maffei. È dunque molto probabile che l’intervento del Maffei sia stato più ampio; una successiva revisione potrebbe essere stata fatta dai due a Firenze, durante leprove del Macbeth. Nonostante le modifiche apportate dal Maffei – e da Verdi – il libretto del Macbeth fu criticato, soprattutto per quella parte che aveva rifatto il Maffei.
Queste sono, in sintesi, le fasi preparatorie che consentirono al Maestro di iniziare la composizione del Macbeth, da cui ripartirà per il rifacimento dell’opera per le scene francesi.
Entriamo ora con il Maestro a Firenze. Verdi, insieme a Emanuele Muzio, arriva nella città toscana a metà febbraio del 1847. Maestro e allievo vanno ad alloggiare alla Pensione Svizzera in via de’ Tornabuoni dove, come scrive Muzio, «abbiamo un magnifico appartamento, con aria di paradiso, ed una tavola da re». Verdi, quattro giorni dopo così scrive all’amica Clara Maffei: «Sono qui da Giovedì mattina, e non le ho scritto jeri perché non era giorno di posta. Ho fatto un viaggio felicissimo e stò bene anzi stò meglio, perché come mi succede sempre il viaggio mi giova. […] Il Macbet andrà in scena piuttosto tardi. Intanto si fa la Sonnambula, poi si fanno alcune recite dell’Attila indi il Macbet».
Firenze, l’«Atene d’Italia», con il suo ambiente politicamente moderato e culturalmente cosmopolita, appare come uno spiraglio aperto sull’Europa. La città si apre a Verdi grazie alla presenza di Andrea Maffei, che da anni la frequentava assiduamente. Tra gli amici fiorentini del Maffei ricordiamo Giovan Battista Niccolini e Gino Capponi, che lo tengono in altissima considerazione, come poeta e traduttore, ma anche come esponente e interprete di idee liberali. Il soggiorno di Verdi a Firenze è piacevole e gratificante; come ci ricorda Muzio, «il Maestro è idolatrato, cercato e ricercato da tutti! Gli uomini più celebri hanno desiderato di conoscerlo; Niccolini, Giusti, Bartolini, Dupré e perfino il Gran Duca lo ha mandato ad invitare , ieri sera c’è andato un po’ malvolentieri». Anche gli scultori Bartolini e Dupré facevano parte delle relazioni fiorentine del Maffei; simpatico è il primo incontro del Maestro con Dupré avvenne per caso, come ci racconta lo stesso artista: «in quel tempo venne a Firenze Giuseppe Verdi per mettere in scena il Macbeth. […] la sua fama lo aveva preceduto; nemici, com’è naturale, ne aveva dimolti; io ero partigiano dei suoi lavori allora conosciuti, il Nabucco, i Lombardi, l’ Ernani, e la Giovanna d’Arco. I suoi nemici dicevano che come artista era volgarissimo e corruttore del bel canto italiano, e come uomo lo dicevano un orso addirittura, pieno d’alterigia e d’orgoglio, e che sdegnava di avvicinarsi a chicchessia. Volli convincermene subito. Scrissi un biglietto in questi termini: «Giovanni Dupré pregherebbe il chiarissimo maestro G. Verdi di volersi degnare a tutto suo comodo di recarsi al suo Studio, ove sta ultimando in marmo il Caino, e desidererebbe mostrarglielo prima di spedirlo! Ma per vedere fino a che punto era orso, volli portar la lettera io stesso e presentarmi come un giovane di studio del Professore […]». Il Maestro fu divertito da questo comportamento da «artista»…. Verdi e Dupré si videro quasi ogni giorno; fecero alcune gite nei dintorni; visitarono la Fabbrica Ginori, andarono a Fiesole, alla Torre del Gallo. Erano una «brigatella» di quattro o cinque persone: Andrea Maffei, il Manara, Giulio Piatti, Verdi, e lo scultore Dupré, che aveva il permesso di assistere, quando voleva, alle prove del Macbeth. Dupré voleva fare un ritratto a Verdi ma, per problemi di tempo, riuscì a formare solo la sua mano in «atteggiamento di scrivere»!! Mano che lo scultore regalò alla Società Filarmonica Senese.
Finalmente, il 14 febbraio 1847 va in scena il Macbeth. In una lettera alla famiglia Barezzi Muzio così racconta: «Ieri sera fu la grande rappresentazione del Macbeth, un immenso fanatismo, avendo dovuto comparire sul palco nel corso della rappresentazione 38 volte […] Nel sortire che feci con Verdi dal teatro fossimo attorniati da un’immensità di popolo e questi ci accompagnarono in mezzo agli evviva sino al nostro albergo essendo distante dal teatro quasi un miglio; Verdi, di quando in quando dovette fermarsi a ringraziare la popolazione fiorentina, quale era composta della prima gioventù. Mi dimenticavo di dirvi che alla prima sera vi fu una calca terribile; aprirono il teatro alle 4 e dopo pochi minuti il teatro era pieno […] L’opera incominciò alle 8 precise e subito fu applaudita l’introduzione e chiamato fuori il Maestro. Fu pure replicato il duetto fra la Barbieri e Varesi, come anche altri due cori, ed il Maestro in tutto il corso dell’opera fu chiamato fuori 27 volte.» […] Anche Giuseppe Giusti, pochi giorni dopo la prima, si affretta a scrivere al Maestro:
«Lunedì passato mi dispiacque di non trovarti in casa, perché dovendo assentarmi da Firenze per quattro o sei giorni avrei desiderato vederti prima di partire. Il tuo lavoro più sarà riprodotto, più sarà inteso e gustato, perché il buono di certe cose non s’afferra alle prime. […] La musica è favella intesa da tutti, e non v’è effetto grande, che la musica non valga a produrre. Il fantastico è cosa che può provare l’ingegno e l’animo.[…]» Queste idee, il Giusti, le aveva ben espresse nella sua poesia Sant’Ambrogio, dove aveva citato il Maestro:
Dopo la prima il critico Enrico Montazio su «La rivista di Firenze» presentò i Primi cenni sul «Macbeth» di G. Verdi. Il critico scrive di un «grandioso musicale lavoro, posto in scena con molta cura e con non ordinario apparato», elogiando soprattutto la Barbieri e i cori (che «non cantaronomai con tanta religione») ed esprimendo il suo giudizio globale: «il Macbeth, se in due sere puossi giudicare di sì imponente lavoro, sembraci, per musicale filosofia e per strumentale ricchezza e venustà, una delle migliori e forse la più bella e perfetta opera del Verdi». Dopo pochi giorni comparvero altre critiche, incentrate su due aspetti: il libretto e la realizzazione della componente «fantastica». Al libretto furono attribuite le debolezze e i difetti della musica. Nel numero speciale del 27 marzo (13 giorni dopo la prima) apparve un lungo articolo del Montazio intitolato «Profanazione inquattro atti di F. M. Piave»
Il «Ricoglitore fiorentino» invece, nell’articolo Prima rappresentazione del Macbeth del M. Verdi, sosteneva di aver sentito dire che i versi dell’opera dovevano attribuirsi alla penna «d’un noto professore», «traduttore elegante di molti be’ lavori di letteratura straniera», alludendo chiaramente al Maffei; in un saggio, pubblicato il 7 aprile, intitolato Estetica melodrammatica.Intorno al «Macbeth» e ad altri melodrammi di questo genere, mette a punto il concetto: «Potrei di più far notare che Shakespeare scrivendo il Macbeth non faceva che incarnarvi credenze de’ suoi tempi e interessi nazionali. […] Ma come a noi riportate le streghe ormai bandite, e schernite sin da fanciulli, e farne come il fato degli antichi, e tentare che la musica avesse tanto potere come talvolta è avvenuto d’attrarre le menti inferme d’alcuno da porlo ancora in sospetto della loro esistenza? […] Ma di grazia in questo Macbeth ov’è un segno di principio morale? Non si tratta che di delitti, di assassini e di sangue freddo spaventoso nel compierli». Il Montazio, da parte sua, continua la sua critica addentrandosi nel concetto di «fantastico»; mettendo in evidenza quello che lui chiama «fantastico metafisico», una illusione tutta moderna «di raffigurare ad evidenza un concetto morale» con la musica, cosa che, per lui, è impossibile (al contrario della capacità descrittiva della musica) ritenuta però sconveniente a teatro – come il levar del sole nell’Attila, definito dal critico “una piccola prova di ultrafilosofia” del tutto superflua. Risulta chiaro che quello che veniva passato sotto la «lente» non è l’opera in sé, ma l’operato di Verdi. Quello fiorentino è un pubblico colto, preparato e, grazie anche all’impresario Lanari, abituato a rappresentazioni di alto livello. Continua così il Montazio: «or ecco la grande colpa del Verdi – Invece di immergere l’immaginazione in fantasticherie commoventi, invece di condurla a spaziar nell’infinito, col vincolare l’armonia alla parola, egli viene uccidendo il fantastico. […] Meyerbeer e Weber, quei grandi maestri di fantastica armonia ridotta a drammatiche dimensioni, ogni qualvolta cercarono il fantastico, lo raggiunsero coll’armonia isolata dalle parole, coll’idealizzazione la più eterea della materia e della vita. Sposare, in musica, la fantasia alla parola, è un rinnovare il supplizio di Mezenzio: è come accoppiare un corpo vivo ad un cadavere; tale unione è mostruosa, impossibile». Sono parole dure, e per noi immeritate, queste del Montazio, ma tali da far riflettere su quella che fosse l’intenzione compositiva di Verdi e le aspettative del pubblico fiorentino. È chiaro che non si era creata sintonia tra il pensiero del Maestro e l’immaginazione dello spettatore. Personalmente credo che, sia il Compositore, (che puntava tutto sul «fantastico» in scena) che l’appaltatore (che lo seguì nelle richieste di «come» per lui dovesse essere rappresentato) non tennero conto di «quanto» lo spirito dei fiorentini fosse sensibile al ridicolo. Infatti, nel periodico milanese «La Moda, giornale dedicato al bel sesso» si sottolineano gli aspetti più «critici» della messinscena, cioè: «L’atto terzo è tutto fantastico, tutto apparizioni e streghe che stanno a far la polta con cert’ingredienti strani […] Quest’atto ch’io non sto a sminuzzare, o non fu apprezzato o non fu inteso; fatto sta che non ebbe incontro favorevole. E chi sa che le apparizioni, gli otto re che sfilavano a guisa di grosse marionette tentennando, barcollando dietro una rete nera che faceva veci di nebbia, chi sa, dico non cooperassero alla fredda accoglienza. […] Bisogna confessare che il pubblico non poté porgere attenzione alla musica, esilarato o distratto da tante cose e visioni un po’ troppo fantastiche». Il tentativo della «seduzione visiva» – per la quale tanto Verdi si era «speso» – non aveva avuto il suo effetto anche se (o forse malgrado se), come puntualizza il solito Montazio: «le peripezie sofferte da una macchina di fantasmagoria trasportata da Milano a Firenze per cooperare al fantastico effetto del fantasticissimo Macbeth,nome che unito a quello del maestro Verdi, almeno una volta al giorno risuona ora sulla bocca di tutti i fiorentini, non esclusi i beceri e le ciane, a cui quel nome indigesto fa l’effetto d’uno scongiuro diabolico e d’una stregoneria». I fiorentini pensavano che la macchina «non arriverebbe più, e che il primo trombaio del quartiere avrebbe avuto l’ordine di farne una, quasi che fosse cosa di niuna importanza una macchina di fantasmagoria per l’esito di una musica, e non esistessero tanti e tanti esempi […] di macchine che per la loro esecuzione abbian compromesso le opere dell’ingegno, e mandato in fumo i più bei castelli impresarieschi». Non fu però la «macchina» ad essere un problema ma una convenzione del teatro che voleva luce in sala. La fantasmagoria, che al contrario aveva bisogno del buio completo, fu inonoratamente sepolta in cantina. In cantina! Fu così che finì l’aspirazione al fantastico di Verdi. Sicuramente furono usati macchinari sostitutivi, come la famosa rete nera al momento dell’apparizione dei re, per rispettare il più possibile il suo desiderio di «fantastico»…. Verdi dedicò questa sua fatica fiorentina a colui che aveva concorso al suo successo: al suocero Antonio Barezzi, con le parole: Mio caro suocero. Ho pensato sempre di dedicare un’opera a voi che foste per me un padre, un amico, un benefattore; ma circostanze imperiose me lo impedirono sino adesso. Oggi che lo posso vi dedico il mio Macbeth, che io amo tanto fra le mie opere. Il cuore l’offre; che il cuore l’accetti. Vostro affezionatissimo, Verdi.