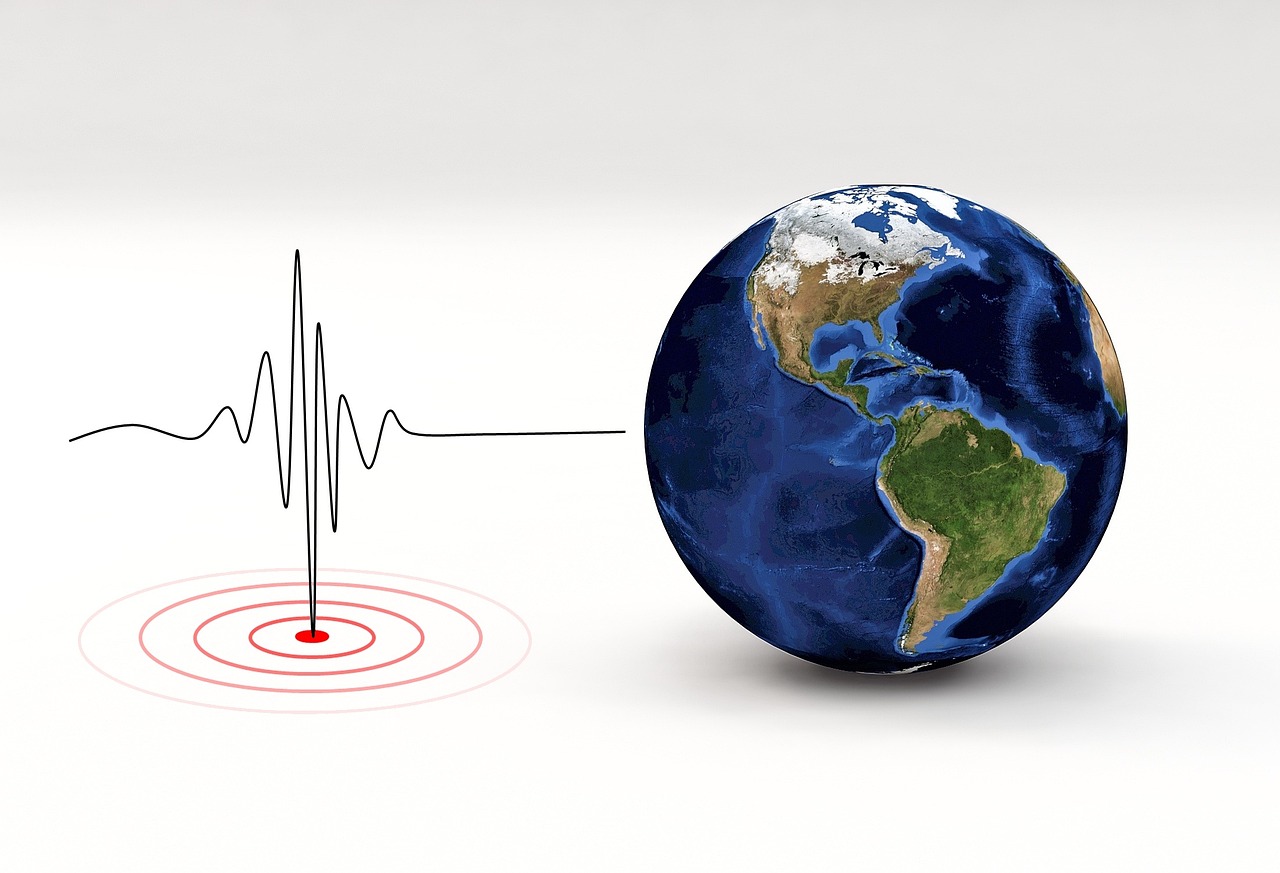Dossier
Perché credo? Rispondono il teologo, il filosofo e lo scienziato
La fede e la ragione, scriveva Giovanni Paolo II in apertura dell’enciclica Fides et Ratio, «sono come le due ali con le quali lo spirito umano s’innalza verso la contemplazione della verità». Più volte queste parole di papa Wojtyla sono state riprese e richiamate dal suo successore che in varie occasioni (ad esempio nel celebre discorso all’università di Ratisbona) ha invocato un «nuovo incontro» tra fede e ragione.
È un’esortazione, questa, che da un lato riguarda il mondo della ricerca scientifica e filosofica: ambienti che molto spesso si sono chiusi verso ogni prospettiva di fede. È a loro, principalmente, che Benedetto XVI ha rivolto l’invito a «un allargamento del nostro concetto di ragione e dell’uso di essa». Una scienza e una filosofia, quindi, che non si autolimitino fermandosi davanti alle grandi domande che abitano nel cuore dell’uomo: «Una ragione – disse ancora in quell’occasione papa Ratzinger – che di fronte al divino è sorda e respinge la religione nell’ambito delle sottoculture, è incapace di inserirsi nel dialogo delle culture». Un concetto che Benedetto XVI ha espresso con parole ancora più forti nel discorso al Collège des Bernardins di Parigi: «Una cultura meramente positivista che rimuovesse nel campo soggettivo come non scientifica la domanda circa Dio, sarebbe la capitolazione della ragione, la rinuncia alle sue possibilità più alte e quindi un tracollo dell’umanesimo, le cui conseguenze non potrebbero essere che gravi».
Ma l’esortazione del Papa è anche un invito rivolto a tutti i cattolici. È il richiamo ad essere capaci di rendere ragione di fronte al mondo della propria fede, proponendo il Vangelo in una prospettiva di ragionevolezza. Non è certo una esigenza nuova: in fondo è la stessa che Pietro rivolgeva ai primi cristiani, quando scriveva loro «Siate sempre pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi». Ma nel nostro tempo, di fronte a un pensiero «laico» che ha cercato di togliere alla fede ogni «diritto di cittadinanza» nel dibattito culturale e scientifico, forse più di ieri il cristiano è chiamato a trovare le parole per dire le ragioni del proprio credere; a saper spiegare e argomentare, senza complessi di inferiorità, la propria fede.
Per questo, in occasione della Pasqua (cuore e vertice della fede cristiana) abbiamo voluto chiedere a tre persone abituate «per mestiere» all’uso della ragione (un teologo, un filosofo, uno scienziato) di spiegarci la loro scelta di fede. «Perché credo» è il tema che abbiamo sottoposto loro, e che ognuno ha sviluppato secondo la propria prospettiva. Ne è venuto fuori un confronto «alto» sulle ragioni della fede, che offriamo ai nostri lettori come contributo e come stimolo perché ciascuno possa cercare anche le ragioni del proprio credere.
Perchè credo? Provare a rispondere a questa domanda è tremendamente difficile (impossibile?) da una parte, e paradossalmente del tutto semplice da un’altra. Tremendamente difficile…perchè si tratta di entrare, per così dire, all’interno del Mistero: il Mistero che è Dio e la sua volontà, e il mistero che è la persona umana, il suo cuore, la sua libertà.
Certamente un’altra parola aiuta non a «risolvere», bensì a rendere più familiare l’orizzonte del Mistero ed è la parola «grazia». «Tutto è grazia», dice il parroco di Ambricourt al termine del noto romanzo di Bernanos, Diario di un curato di campagna. E questo, dal tempo in cui poco più che adolescente ho letto questa frase, si è sempre più evidentemente documentato. Pura grazia di Dio essere venuto al mondo, pura grazia essere cresciuto in un ambiente familiare accogliente, pura grazia aver un giorno – come dirò dopo – percepito che il Mistero era un Volto familiare, anzi, «quel» Volto desiderato e inconsciamente cercato in tutti i volti delle persone circostanti; in fondo, posso ora riuscire ad intravedere qualcosa di quanto Dante voleva esprimere, nel 33° canto del Paradiso, descrivendo l’esperienza della visione di Cristo: «quando dentro da sé, dal suo colore stesso,/mi parve pinta de la nostra effige:/per che ‘l mio viso in lei tutto era messo».
E tuttavia in me questo caro e misterioso Volto si è fatto conoscere del tutto umanamente, proprio perchè è un Volto umano. Dio è «diventato Gesù» – amava ripetere don Giussani – proprio per farsi conoscere umanamente, sensibilmente, affettivamente: per questo è stato semplice per me riconoscerlo, potergli dire «Tu». L’incontro con Lui è coinciso – e coincide tuttora, a distanza di trent’anni, certo con più consapevolezza ma col medesimo «stupore» di allora – con l’incontro di persone prese, afferrate, cambiate da Lui; persone che facevano (e fanno) trasparire una «febbre di vita» inusuale, mai sperimentata prima, a cui non potevi non domandare: «cos’è che ti fa vivere così»? E la risposta – sentita allora come strana e tuttavia del tutto «ragionevole», in quanto non erano rintracciabili altri motivi più esaurienti – era una sola: «Gesù»!
Per questo è stato semplice «credere»: non ha richiesto un particolare sforzo, non è stato il prodotto di singolari «visioni», ma è stato piuttosto il cedere di fronte all’evidenza di un’attrattiva, tanto nuova quanto corrispondente alle proprie attese, a cui tuttavia non potevo dare io il nome, bensì mi era dato, consegnato da una realtà umana che mi raggiungeva nel presente, la cui origine però era antica: e portava i nomi di Giovanni e Andrea, Pietro e la Maddalena. Come faceva dire Peguy a Madama Gervaise ne Il mistero della carità di Giovanna d’Arco: «Egli è qui. È qui come il primo giorno. È qui tra di noi come il giorno della sua morte. In eterno è qui tra di noi proprio come il primo giorno. In eterno tutti i giorni. È qui fra di noi in tutti i giorni della sua eternità È la medesima storia, esattamente la stessa, eternamente la stessa, che è accaduta in quel tempo e in quel paese e che accade tutti i giorni in tutti i giorni di ogni eternità».
Perchè credo? Perchè quel presentimento del vero presente già nel primo incontro – incontro, ripeto, normalissimo e tuttavia già carico di una grande promessa – si è confermato, crescendo in consapevolezza e certezza, nel tempo. Come annota il Vangelo di Giovanni, descrivendo la reazione dei discepoli di fronte ai «segni» che compiva il Maestro: «e credettero in Lui». Non una volta sola, ma ogniqualvolta si rinnovava l’esperienza della sua eccezionalità: «e credettero in Lui».
D’altra parte, più passa il tempo e più mi accorgo che quanto descrivono i Vangeli è proprio vero! Altro che racconti simbolici, narrazioni poetiche da demitizzare…ciò che i miei occhi vedono, le mie mani toccano, i miei orecchi odono – sempre per dirla con l’apostolo Giovanni – è la medesima realtà che altri prima di me – i discepoli di Gesù, appunto – hanno sperimentato e quindi tentato di raccontare, per come potevano, nei santi Vangeli. E quei tratti inconfondibili di Gesù lì descritti possono essere rivisti all’opera nel tuo presente; d’altra parte Lui stesso l’aveva preannunciato: «Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo» (Mt 28,20). Il metodo rimane così il medesimo di quello indicato a Giovanni e Andrea, la prima volta, sulle rive del Giordano: stare con lui, vedere dove «abita». Così «credere» non diventa un salto nel buio e non bisogna affatto «credere di credere»: mi dispiace, ma non è assolutamente questa la mia esperienza della fede, né ritengo sia quella autenticamente cristiana. Per «credere di credere» non c’era bisogno, per dirla ancora con Peguy, che «Dio si scomodasse» diventando Uno fra noi.
Perchè allora credo? Se la ragione ultima, come dicevo all’inizio, risiede nel mistero della volontà e libertà di Dio, dal mio punto di vista risponderei così: perchè ciò corrisponde totalmente alla mia umanità – al «cuore», direbbe la Bibbia: al desiderio di eternità, di verità, di amore, di giustizia. Chi più di Gesù ha risposto e risponde a questo? Chi riesce a «salvare», già ora (è il centuplo promesso) e per l’eternità il grido del nostro io? Nella mia esperienza, e in quella di tantissime persone che ho conosciuto – confermata, poi, dalla testimonianza autorevole e commovente degli ultimi successori di Pietro – il dire sì a Gesù spalanca la vita ad un orizzonte di umanità altrimenti introvabile. È ciò che Giovanni Paolo II ha scritto nella sua prima enciclica e che poi ha testimoniato lungo tutto l’arco della sua grandissima esistenza. E sono queste le parole che forse meglio esprimono quanto ho cercato di comunicare, rispondendo alla domanda rivoltami: «L’uomo non può vivere senza amore. Egli rimane per se stesso un essere incomprensibile, la sua vita è priva di senso, se non gli viene rivelato l’amore, se non s’incontra con l’amore, se non lo sperimenta e non lo fa proprio, se non vi partecipa vivamente. E perciò appunto Cristo Redentore (…) rivela pienamente l’uomo all’uomo stesso. Questa è – se così è lecito esprimersi – la dimensione umana del mistero della Redenzione. In questa dimensione l’uomo ritrova la grandezza, la dignità e il valore propri della sua umanità».
La scelta della fede non è mai stata facile. Oggi, forse, lo è ancora meno. Perché sembra che l’alternativa in cui ci possiamo muovere per intendere la fede sia oggi fra due poli estremi, opposti: il polo del disinteresse per le questioni religiose, da un lato, e quello dell’assunzione dogmatica di certi principî, dall’altro. Indifferenza oppure fondamentalismo: pare che il nostro rapporto alle cose religiose, e il modo in cui intendiamo la fede, oggi non possa sfuggire a questa alternativa.
D’altronde una tale situazione è quella che molto spesso, davanti ai mondi religiosi, viene veicolata dai mezzi di comunicazione di massa. Sembra che non vi possa essere un rapporto costruttivo tra credere e pensare. Pare che, nel quadro delineato, l’unica soluzione sia quella o di lasciarsi alle spalle, senza rimpianti, tutte le questioni religiose, oppure d’intendere la fede come una scelta immotivata, o relativa alla psicologia individuale, e viverla quale sostegno di un atteggiamento intransigente. Ma così non solo la scelta di fede viene fraintesa nel suo significato più profondo: più ancora, la sua stessa espressione pubblica, nella vita di tutti i giorni, è destinata a essere limitata a uno spazio ristretto. E, in tal modo ghettizzata, la fede finisce per essere irrilevante.
In questa situazione già così complicata le cose si complicano ancora di più per chi, come me, si occupa per mestiere di cose filosofiche. Niente di troppo astruso, a ben vedere, la filosofia. Solo un particolare modo di pensare il mondo, l’uomo, lo stesso Dio, adottando specifiche categorie concettuali e assumendo un particolare atteggiamento di distacco nei confronti dei propri temi. E niente, come si vede, di pregiudizialmente ostile all’ambito religioso, come dimostra la storia stessa della filosofia. E tuttavia sono ormai passati i tempi in cui era dato per ovvio il legame tra fede e ragione: un legame che era basato sulla consapevolezza, per un verso, dei propri limiti da parte di chi faceva uso mondano della ragione e, per altro verso, della ragionevolezza dei propri assunti da parte di chi faceva professione di fede. Oggi invece risulta egemonico, un concetto diverso di ragione: quello messo in opera dalle scienze, che tutto vogliono spiegare e controllare. E dunque non si tratta più d’intendere i limiti della ragione come condizione per il passaggio a una dimensione ulteriore, giacché questo passaggio non è più scontato. Bisogna pensare nuove forme di ragione e altri modi, per essa, di esercitare il suo possibile collegamento alla fede.
Sono tutte cose complesse, mi direte. Che non è necessario affrontare per vivere pienamente un’esperienza credente. La quale è, a ben vedere, qualcosa di lineare: è un libero, fiducioso affidarsi a una dimensione altra che mi prende, mi coinvolge, mi guida. In questa prospettiva le anime semplici entrano probabilmente nel Regno dei Cieli molto prima e molto più facilmente dei tanti filosofi (ma, forse, anche dei tanti teologi) che speculano sull’argomento.
Ciò ha molto di vero. Ma penso che lo specifico affidarsi a una dimensione «altra» possa essere vissuto in maniere diverse, a seconda delle persone che ne sono coinvolte e dei loro modi di pensare. Senza che questo generi, naturalmente, una babele d’interpretazioni. Ma tenendo conto delle molte sensibilità, dei vari apporti, delle innumerevoli tradizioni che confluiscono nella storia del cristianesimo e ne caratterizzano la specifica vitalità.
E dunque in tale prospettiva può ben trovare spazio anche la fede del filosofo. Nonché il suo sforzo incessante per coniugare in modi adeguati al proprio tempo vocazione al pensare e scelta di credere, esercizio del dubbio e assunzione di un orizzonte da accogliere stabilmente, necessità di distaccarsi dalle cose per guardarle in modi sempre nuovi e possibilità d’individuare uno spazio complessivo in cui tutto possa trovare senso. Certo: non è un compito facile. Ma affrontarlo può essere utile. Ed è sulla base di questa convinzione che personalmente cerco di portare avanti insieme, nello spazio pubblico, il mio specifico approccio e le mie convinzioni di fondo.
Dicevo prima che uno dei miti da sfatare oggi è quello dell’incompatibilità di fede e sapere. I due atteggiamenti possono essere opposti solo se si concepisce la conoscenza in un modo particolare: come la intende per lo più la riflessione scientifica. Le scienze vogliono dare una spiegazione del mondo allo scopo di dominarlo e per far sì che esso possa venire comodamente abitato. Quando poi si è visto che l’ipotesi-Dio non era necessaria a tale spiegazione, se ne è fatto a meno. L’uomo stesso, poi, è diventato l’oggetto di tutta una serie di discipline «antropologiche» (etnologia, sociologia, psicologia, psicanalisi, ecc.), volte a chiarirne e a controllarne i processi.
Non di spiegazioni, però, è alla ricerca in primo luogo la fede. Essa è apertura di senso, offre orientamento, delinea uno spazio comprensivo all’interno del quale collocare il proprio agire e il proprio pensare. Di più. All’interno dell’esperienza di fede questo spazio non è prodotto dall’uomo, ma s’annuncia come qualcosa di donato. Solo perciò esso può interpellare e coinvolgere.
Anche l’indagine filosofica è alla ricerca di senso. Certo: un senso ricercato non è certamente un senso preliminarmente assunto. In filosofia, cioè, il risultato non può essere anticipato, ma deve sempre poter essere messo in questione. E tuttavia il comune riferimento alla dimensione del senso consente di stabilire un legame fecondo tra sapere filosofico e istanza religiosa. Un legame che, certo, dev’essere testimoniato. Ma che è rafforzato da un’esperienza che chi fa filosofia sovente compie, al di là degli schematismi veicolati nel tempo presente: cioè la scoperta, in un processo di ricerca onesto e spietato, che i nodi di fondo che l’indagine filosofica affronta, o che semplicemente intravede, sono gli stessi a cui la fede cristiana da sempre fa riferimento e che è chiamata ad annunciare. È proprio tale scoperta ciò che sostiene l’attività filosofica del cristiano.
La peculiarità che distingue il testo biblico consiste nella convinzione che esista una profonda e inscindibile unità tra la conoscenza della ragione e quella della fede. Il mondo e ciò che accade in esso, come pure la storia e le diverse vicende del popolo, sono realtà che vengono guardate, analizzate e giudicate con i mezzi propri della ragione, ma senza che la fede resti estranea a questo processo. Essa non interviene per umiliare l’autonomia della ragione o per ridurne lo spazio di azione, ma solo per far comprendere all’uomo che in questi eventi si rende visibile e agisce il Dio di Israele» (Fides et ratio, 16).
Il testo della Fides et ratio segnala l’esistenza di una profonda e inscindibile unità fra la conoscenza della ragione e quella della fede. In effetti, è proprio sulla mancanza di questa unità che sono costruite le preclusioni a un discorso su Dio di molti uomini di scienza di oggi.
Storicamente, la scienza moderna si è costituita attorno a due auto-limitazioni. La prima – enunciata da Galileo a Marco Welser nel 1610, consiste nel «non tentare le essenze, ma contentarsi delle affezioni quantitative». In altre parole, si ritagliano da un fenomeno solo quegli aspetti suscettibili di misura; si ha così un pacchetto di numeri con cui si cerca di ricostruire il fenomeno, avendo eliminato tutti gli aspetti non misurati. Una manipolazione formale, puramente sintattica, di un pacchetto di simboli, senza attribuire ad essi un significato, è il modo di procedere di un calcolatore; ne è emersa la convinzione che la ragione operi come una macchina di calcolo sui dati misurati o percepiti, senza attribuire ad essi alcun significato.
La seconda auto-limitazione è nata con il tentativo di indovinare le carte nel gioco d’azzardo (Bayes,1763). Nello sviluppare un ragionamento, si formula un ventaglio di ipotesi a-priori con diversi gradi di probabilità. Ognuna di queste ipotesi, introdotta in un modello di mondo, genera un dato. Misurando quali dati effettivamente si verifichino, si costruisce una probabilità a-posteriori che automaticamente seleziona fra tutte le ipotesi a-priori solo la più plausibile.
Questa procedura di inferenza è generale. L’evoluzione di Darwin può essere vista come figlia di Bayes: una «mutazione» dà luogo a molte varianti geniche che entrano come ingresso di un programma (il modello di vivente cui si riferiscono); il successivo confronto con l’ambiente seleziona il fenotipo più plausibile e conferma una sola variante, la più favorevole.
La procedura di Bayes ha influenzato tutta la cultura scientifica dell’800; Sherlock Holmes risolve i casi criminali in modo bayesiano. Ma la procedura è trasferibile a una macchina di calcolo; infatti, negli ospedali si usano «expert systems» che istruiti con un modello umano e riforniti dei dati clinici di un paziente, emettono la diagnosi più plausibile. In effetti, i successori odierni di Sherlock Holmes nei polizieschi americani sono super-computers in cui si immettono i dati e che risolvono bayesianamente il caso.
La scoperta recente di situazioni complesse indica che in presenza di molte variabili non si ha mai una soluzione unica a un problema; spesso il numero delle possibili soluzioni cresce in modo esponenziale con il numero di variabili. L’inferenza di Bayes esplora solo un possibile percorso; la ragione sintattica – o il computer per essa – si arrampica con successo su quell’unico percorso e ignora gli altri.
Pertanto, le due auto-limitazioni della ragione scientifica (Galileo e Bayes) non forniscono indicazioni procedurali in situazioni complesse. Il fatto che invece la mente umana riesca con successo a costruire modelli alternativi indica che la nostra visione del mondo non è bayesiana, ma cattura quei significati che sfuggono alla procedura scientifica.
È questo che chiamiamo creatività. Ne diamo un esempio. Nel 1931, Gödel mostrò che la mente umana può costruire teoremi che non sono deducibili per pura via sintattica a partire da un corpo di assiomi e pertanto non sono «dimostrabili». Più in generale, andando oltre il campo delle scienze della natura, ogni combinazione nuova e significativa di elementi lessicali (le parole di una lingua, le note musicali) è un atto di creazione. Il nostro essere immersi nel mondo in modo non auto-limitato dalle procedure scientifiche fa sì che ci sia la poesia di Leopardi o la musica di Mozart.
Dunque, il fatto che il mondo sia complesso vuol dire che in genere non è racchiudibile in un modello unico. Come scegliere allora fra più modelli alternativi? Ci si prospettano due modi di leggere i salti creativi:
1. arbitrio = relativismo (è la scelta del «pensiero debole»),
2. si opera sulla base di criteri guida, quali: fecondità e latitudine della nuova spiegazione; possibili applicazioni utili, il che vuol dire conquista di un’armonia nel dialogo con l’ambiente. Si scopre così il riflesso di una ontologia, la realtà che ci circonda ha senso; dunque, dobbiamo riconoscere che il salto creativo non è arbitrario, ma guidato dalla situazione entro cui ci troviamo.
Nell’esplorare diversi codici di lettura, ri-aggiusto il codice fino ad armonizzare percezione ed azione; ma questo riaggiustamento è la base della verità, definita da Tommaso d’Aquino come adaequatio intellectus et rei.
Tornando alla frase di Fides et ratio da cui siamo partiti, la ragione incarnata può anche di diritto operare su problemi di fede, perché è in grado di evidenziare significati, non solo quantità.
Ma allora, il conflitto fra scienza e fede su cui si disserta nei «talk show»? Essendo il 2009 l’anno galileiano, mi piace concludere con quanto Galileo diceva alla madre del granduca di Toscana: «procedendo di pari dal Verbo divino la Scrittura Sacra e la natura, quella come dettatura dello Spirito Santo, e questa come osservantissima esecutrice degli ordini di Dio… quello che la sensata esperienza ci pone dinanzi agli occhi o le necessarie dimostrazioni ci concludono non debba esser revocato per luoghi della Scrittura che avessero nelle parole diverso sembiante» (Lettera a Cristina di Lorena, 1615).
Ma io, perché credo? È sempre imbarazzante per un uomo di scienza di parlare di se stesso; comunque, rispondo alla richiesta. Anzitutto vediamo quali attitudini siano compatibili con l’impegno scientifico. La prima è di lasciarsi vincolare dalle limitazioni su criticate e ritenere che quanto ci dice la scienza esaurisca il mondo; ma è chiaro che Dio non si manifesta ai miei strumenti né è implicato nelle mie dimostrazioni. Se la scienza esaurisse tutta la realtà, allora non ci sarebbe posto per altro: è perciò che per alcuni la scienza si presenta come una religione alternativa, che soppianta la credenza in Dio. Però abbiamo detto che in situazioni complesse (cioè nella stragrande maggioranza dei nostri contatti col mondo) non si ha mai una spiegazione unica; per farla breve, la prima attitudine non regge.
La seconda è di limitare il potere di una scoperta scientifica alla sua rilevanza tecnica, senza porsi il problema della verità; si potranno fare con successo bombe e manipolazioni genetiche, ma rimangono inevase le domande di fondo che chiunque si pone.
La terza è di riconoscere che il mondo è complesso, che non è esaurito da una descrizione scientifica, e quel che rimane ha ancora senso per la mia vita e devo affrontarlo in modo non-bayesiano: è qui che scopro un codice di lettura creativo (la adaequatio di Tommaso!) che mi mette in contatto con le essenze delle cose (quelle che Galileo aveva rifiutato di esplorare, ma che si ripresentano come problema ineludibile); allora si ripropongono con forza le Vie di Tommaso: le cose sono contingenti, quindi richiedono Qualcuno necessario che le sostenga; le cose si raccordano in una trama coerente, quindi il Qualcuno è Logos, come dice il prologo del Vangelo di Giovanni; ma qui mi accorgo che non sto procedendo per «necessarie dimostrazioni», ho esaurito le mie cartucce scientifiche e devo ricorrere alla parola rivelata.
Per parlarci col nostro linguaggio, e rendersi così comprensibile, è la prima risposta.
Ma andando più a fondo, c’è un aspetto ben più drammatico: la nostra limitazione di uomini è che libertà e esperienza del male sono inestricabili, non c’è l’una senza l’altra. Logicamente il conflitto è insanabile, ma Dio incarnato – Gesù Cristo, assumendo la condizione umana, si è fatto carico di questo conflitto e ci ha salvati: è questo il cuore dell’annunzio cristiano che siamo chiamati a vivere (Lettera ai Romani di San Paolo).
C’è infine una riflessione che mi ripropongo spesso: l’uso del tempo. Il nostro tempo individuale non è quello scandito dall’orologio; un intervallo diventa insopportabilmente lungo se ci stiamo annoiando; al contrario, se stiamo sperimentando qualcosa di esaltante (questo avviene nel rapporto d’amore, o nell’esperienza del bello) il tempo che vi dedichiamo sembra molto breve. Nelle mie letture di ragazzo, ricordo la riserva di un filosofo (Benedetto Croce) al paradiso: dopo un po’, ci si deve annoiare perché si è nel ripetitivo; come sopportarlo per l’eternità?
Orbene, quanto detto sulla contrazione del tempo individuale vale in grado sommo, quando – come dice Giobbe – mi toccherà di vedere il volto di Dio: sarà una tale gioia che il tempo non passerà mai; è questo il senso della mia attesa, che riempio vivendo gli impegni del mio quotidiano.