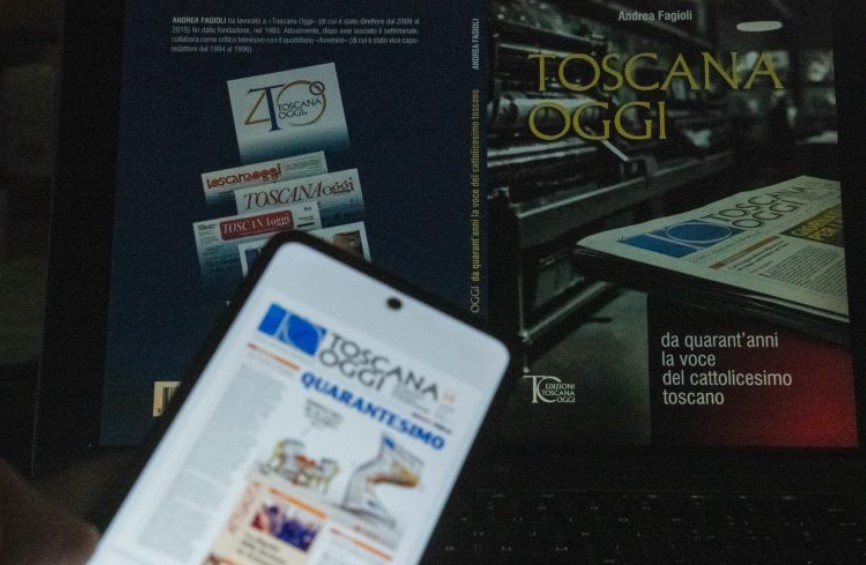Cultura & Società
Figure e leggende di briganti toscani

di Carlo Lapucci
La Toscana, a livello di tradizione orale è, meglio dire era, ricca di storie di briganti, le quali erano oggetto di citazione, narrazione anche nelle veglie. Tuttavia, se si indaga sulla situazione attuale di questi racconti, si nota che le storie sono pressoché tramontate col finire dell’importanza e la simbologia sociale rivestita dai briganti nel passato non molto remoto. La Maremma, che è la culla di questa tradizione, conserva ancora molti ricordi, che nel resto della regione non sono altrettanto vivi, ma direi sono quasi spenti: Gnicche, Stoppa, Tiburzi, Fioravante non accendono nessun ricordo anche nelle persone più anziane. Forse sono più vivi nella costa settentrionale i ricordi di anarchici come Caserio. L’ingiustizia delle cose umane, delle leggi e della distribuzione dei beni nella società ha fatto sì che in momenti di maggiore oppressione si sia potenziato il mito del brigante. Mitica appunto è stata questa figura nel passato prossimo della Toscana e dell’Italia, dove il brigantaggio ha costituito un fenomeno di massa dopo l’unità italiana, e tale dimensione è ancora presente nelle composizioni dei cantastorie che celebravano le gesta dei vari briganti locali nelle fiere e nei mercati.
In questa luce il brigante è il vendicatore delle ingiustizie legalizzate dei potenti e dei prepotenti, l’instauratore d’un sia pur precario nuovo ordine contrapposto a quello vigente che si presenta intollerabile.
Stefano Pelloni, detto il Passatore, fu il campione di questa tipologia di brigante-signore, di brigante-difensore dei poveri, di brigante-gentiluomo, ovvero obbediente più a un indefinito ideale di giustizia, che all’avidità della rapina e dell’accumulazione di ricchezze. Come tutti i ribelli il brigante tende a seguire, a suo modo, le leggi non scritte dell’umanità, piuttosto che quelle scritte del diritto. In genere nessun brigante muore ricco; qualcuno lascia un tesoro nascosto di cui si favoleggia ancora, come a Orentano si ricerca quello dell’Orcino.
In Toscana le gesta dei briganti sono passate anche in detti e proverbi. Il rifugio del brigantaggio toscano è la Maremma, dove le guardie non hanno potere; tuttavia i banditi vivono anche altrove, nelle foreste, sulle montagne, favoriti e ospitati dai boscaioli, dai carbonai. Aiutati dai contadini e dagli artigiani entrano nei paesi, nelle città, partecipano in incognito alla vita pubblica, nelle feste, nei teatri, per farsi riconoscere un momento prima di sparire di nuovo nella campagna ed eclissarsi nel bosco. Nel secolo scorso si assiste a un pullulare di briganti: Domenico Tiburzi è il re del Lamone, Federico Bobini, detto Gnicche, opera in quel d’Arezzo, Barbanera in Lucchesia, l’Orcino e la sua banda spadroneggiano nella zona di Bientina, il Passatore opera anche in Toscana. La Maremma è anche l’asilo di ricercati e fuoriusciti: il più stravagante è David Biscarini che usa portare infilata nella fascia del cappellaccio una coda di volpe rossa; e ce ne sono altri come Vincenzo Pastorini detto Cenciarello, Giuseppe Basili detto Basilietto, Enrico Stoppa detto Rigetto o re di Talamone, Fortunato Ansuini, Damiano Menichetti…
Erano questi il Gotha del brigantaggio, ma c’era anche l’artigianato e la manovalanza: gente che lavorava in piccolo e si nascondeva in zone più ristrette e altrettanto favorevoli: nella Val di Chiana, nelle Crete senesi, nelle foreste dell’Amiata.vTalvolta nei paesi i briganti avevano in incognito famiglia e figli, o amori segreti che alla fine li tradivano. Cavallereschi o spietati, sempre la morte li illuminava conferendo loro un alone di gloria, eroismo e sventura.
La vallata dell’Arbia, Montepescini, Murlo, Vescovado, Buonconvento, Pienza, la zona dell’Amiata, Monteroni, Montalcino, San Quirico d’Orcia, la Maremma, nella seconda metà dell’Ottocento, videro le gesta di Giovanni Turchi, detto Baicche o Bachicche, catturato nei pressi di San Quirico e condannato poi all’ergastolo. Tuttavia i briganti non hanno avuto né la forza, né il tempo per diventare leggenda. Inoltre l’epoca non li ha aiutati: le loro gesta sono documentate pressoché costantemente sui giornali: la tradizione scritta ha anticipato quella orale, definendo il fatto, abolendo l’attività fantastica, cancellando la distanza di tempo e spazio, elemento fondamentale per sfumare le figure, conferire loro una dimensione eroica, simbolica, una grandezza positiva o negativa, vale a dire quelli che sono i presupposti del leggendario. Il popolo insomma, o i suoi bardi, non hanno fatto in tempo a prestare loro la propria anima, ad assimilarli, ricrearli, riconoscervisi ed accettarli nella loro apoteosi. Sorte ancora peggiore, dal punto di vista della leggenda, hanno avuto i garibaldini.
D’altra parte i contrasti sociali si sono avviati, già nel periodo nel quale i briganti operavano, verso altre forme di protesta, di lotta. I briganti poco avevano da dire fuori dalla foresta, loro ambiente naturale, restando comunque oggetto di simpatia e d’ammirazione, soprattutto per la loro azione immediata e sbrigativa, più di vendetta che di giustizia.
Nondimeno i briganti hanno le loro saghe, i loro cantastorie che li hanno celebrati e, nel leggendario collettivo toscano, ci sono anche loro, ma presentano più un informe materiale leggendario che leggende vere e proprie.
Altra cosa, per fare un esempio, è la figura di Ghino di Tacco, il brigante medievale di Radicofani, che ha invece la sua dimensione leggendaria, della quale già per tempo si è impadronita la letteratura a cominciare dal Boccaccio.
A volte si travestiva per andare a un ballo o a una festa e non aveva paura d’essere riconosciuto, perché quelli che avevano fatto la spia li aveva messi tutti sotto terra.
Una sera di festa entrò in un paese, vestito come un figurino, e andò a prendersi un caffè, sedendosi a un tavolo del bar più frequentato del posto.
Parecchi lo riconobbero e bisbigliavano:
Al vero sindaco prese una tale tremarella che gli cadde la tazza di mano, poi, facendo scongiuri e segni di croce, andò a chiudersi in casa, mettendo tutti i paletti, le spranghe e le serrature che aveva alle porte e alle finestre e per parecchi giorni non fu visto in giro.
Settimio Menichetti fu il brigante che ereditò la macchia della Maremma alla morte di Tiburzi, ma non fu grande come il predecessore: era poco avveduto toccando gente pericolosa, incapace di farsi amici contadini e boscaioli, troppo crudele, attirandosi vendette e per una di queste morì. Avendo catturato un possidente chiese alla famiglia un riscatto eccessivo, che fu pagato, ma spinse la vittima a vendicarsi. Così, tornato a casa, il possidente, per mezzo di spie, tenne d’occhio i movimenti dei briganti e un giorno fece sapere ai carabinieri che Menichetti, con Albertini e Ranucci, era alle macchie del Crocino. I carabinieri andarono a cercarli e i briganti, che sempre s’aspettavano una sorpresa, avevano preso le loro misure, preparando postazioni e vie di scampo. Sicuri come sempre, si erano fatti portare da una casa vicina buona roba da mangiare e vino in quantità. Quando furono alla fine del banchetto i carabinieri, che erano avanzati di soppiatto, intimarono la resa. I briganti imbracciarono gli schioppi, convinti di spaventare i gendarmi e filarsela, ma le loro mosse erano quelle di ubriachi insonnoliti e maldestri. Nel vino era stato messo un sonnifero che li aveva intontiti, per cui caddero sotto i colpi dei carabinieri come dei maldestri ladri di galline.
Il museo del brigantaggio a Cellere
Era il 1862 e il 1896 Domenico Tiburzi, passato alla storia come «Il re del Lamone», dal nome della selva di oltre 2 mila ettari che diventò il suo regno, fu uno dei briganti più famosi e temuti d’Italia. Visse per ben 24 anni alla macchia. Nel suo mito, benché fosse bruttissimo e piccolo di statura, tanto da essere soprannominato Domenichino, rientra anche la fama di grande amatore, di appassionato musicologo e frequentatore di artisti. A questo ingombrante personaggio, che in vita era considerato la «vergogna» del suo paese, Cellere, in provincia di Viterbo, l’amministrazione comunale ha dedicato un museo, il Museo del brigantaggio, inaugurato a settembre. A livello nazionale Il Museo del brigantaggio è il secondo dedicato ad un brigante dopo quello di Itri (Latina) dedicato a Fra’ Diavolo. La struttura, che occupa un’ex mattatoio, si trova al numero 20 di Via Marconi ed è tornata a nuova vita grazie alla volontà dell’amministrazione di Cellere egregiamente supportata dalla Regione Lazio e dalla Provincia di Viterbo.
L’originalità del nuovo museo di Cellere è che è nato senza collezioni ma sulle parole, su racconti, ricerche e interviste fatte su e giù per la Maremma tosco-laziale su come ci si viveva appena un secolo fa quando gli ultimi briganti morivano e con loro si concludeva un’epoca.
All’interno, oltre ad oggetti appartenuti a Tiburzi, o della sua epoca, sono esposti anche cimeli di altri noti briganti della Maremma viterbese che furono suoi complici: «Il curato», chiamato così per le sue manie religiose e perché portava con sé decine di santini e libri di preghiere; «Veleno», del quale si dice che fosse ancora più brutto di Tiburzi, e, forse, anche più feroce, ma non aveva il piglio del capo. Ironia della sorte, «Veleno» fu ucciso proprio da un curato (vero e non il suo complice) al quale insidiava la giovane perpetua.
In occasione dell’inaugurazione Fulvia Caruso, responsabile insieme a Vincenzo Padiglione del progetto scientifico museografico, ha sottolineato quanto il nuovo museo sia etno-antropologico e sono state ben 18 le linee di ricerca usate durante i quattro anni di lavoro. Davvero preziose per conoscere la Maremma dell’epoca, le interviste fatte tra il 2005 e il 2006 a «maremmologhi» del calibro di Alfio Cavoli, al quasi centenario Giovanni Travagliati (buttero della Marsiliana), e a quel grande scrittore fiorentino che resta Giorgio Batini, autore del celeberrimo «O la borsa o la vita», un libro ora fuori commercio che resta basilare per la storia del brigantaggio maremmano.
Il neonato Museo del brigantaggio di Cellere resta aperto al pubblico solo il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 17 alle 20.
Antonella Monti