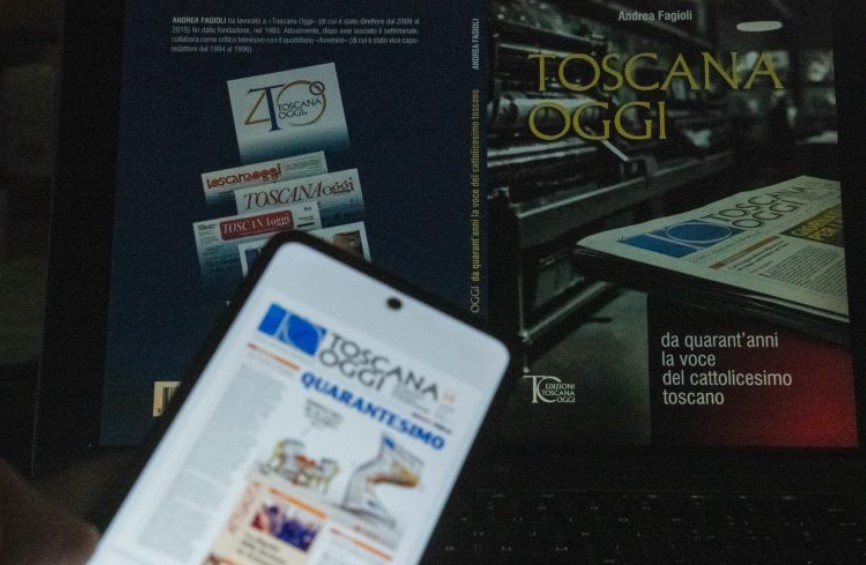Lettere in redazione
Dare dignità alla fine della vita
Link copiato negli appunti
Nel documento riportato di recente su alcuni giornali si legge: «Con le attuali normative esaudire la richiesta di morte di un malato è più economico che curarlo. Con l’eutanasia la medicina si libera di un problema, rottamando una macchina guasta. Con il trattamento del dolore invece si fa carico della sofferenza del malato, dedicando tempo e presenza. La medicina del dolore è infatti anche l’esempio di un nuovo umanesimo biomedico».
Questa civilissima lettera ripropone sia lo sforzo e lo studio della scienza medica, sia il dovere e l’impegno sociale ad alleviare le sofferenze dell’uomo anche quando la malattia rende irreversibile il processo della vita che se ne va.