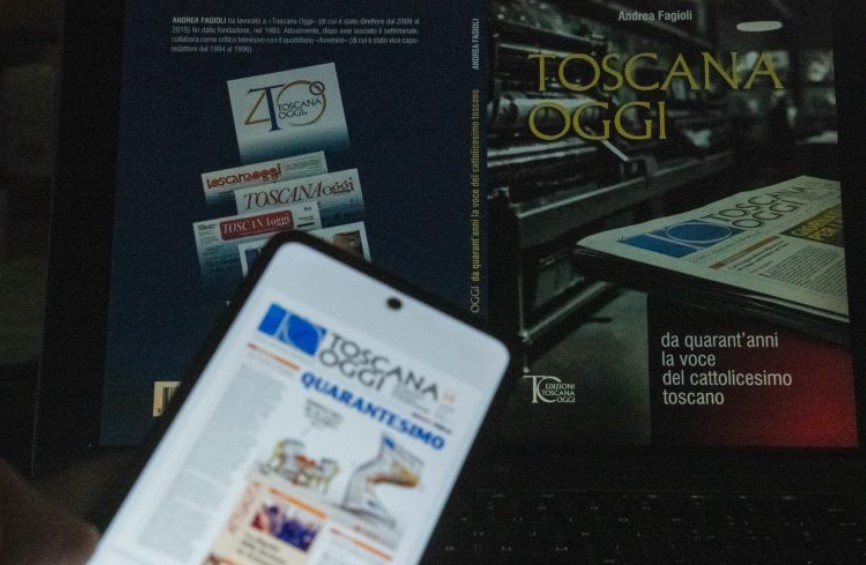Opinioni & Commenti
Gaza, la stessa, assurda e inutile guerra
Nel 2006 fu battezzata «Piogge d’estate». Nel 2008 «Piombo indurito». Nel 2012 «Pilastro di difesa» e oggi «Margine di protezione». Ma è sempre la stessa assurda e inutile cosa anche se fatta da pluriripetenti. Nessuno vince, nessuno cambia, nessuno impara qualcosa. Nessuno ha pentimenti e nemmeno ripensamenti. In modo da non ripetere una storia già vista e risaputa. In modo da potere dire che il sangue versato una volta ha risparmiato un po’ di sangue da versare la prossima volta. Ha detto l’ex-deputato israeliano Avraham Burg, esponente del movimento «La Pace ora»: «Clausewitz sosteneva che la guerra è la continuazione della politica. Qui invece la guerra è solo la continuazione della guerra precedente». E, se ormai si guarda ad un conflitto fra ebrei e palestinesi che con i suoi più che settant’anni di vita è certamente il più lungo di tutta la modernità, viene voglia di risalire a considerazioni più generali per tentare di spiegare questa guerra che ormai si è fatta, sembra quasi per sempre, paesaggio di quel paesaggio dove camminò Gesù.
In fondo nel conflitto arabo- israeliano sembra dominare ancora più che altrove la cultura della guerra. Sull’estremismo islamico che non vede altro mezzo della lotta che quella armata, che continua a lanciare missili che non colpiscono mai il bersaglio, che costruisce rifugi sotterranei per i missili e non per le persone, che rifiuta anche la tregua di un’ora, che proclama vittorie tanto più grandi quanto più immaginarie, pesa senza dubbio l’impronta e la retorica di una tradizione in cui il lato militare è tutto e per cui i sultani mandavano il famoso laccio di seta ai loro generali sconfitti perché si impiccassero. Sulla scelta militare di Israele pesa invece quella predilezione della forza come alternativa e contrassicurazione all’Olocausto che sta alla base stessa della fondazione dello stato ebraico e che paradossalmente conduce ad accettare principi di cui gli ebrei sono stati in passato le principali vittime. Quello, ad esempio, per cui si inizia una guerra in sostanza sulla base dell’assassinio di tre giovani israeliani da parte di qualche palestinese come se ancora un intero popolo fosse responsabile del gesto di un suo fanatico e dovesse pagarne in massa la pena.
Quello per cui la guerra, in base agli occhi in più che in quanto tale può permettersi anche rispetto «all’occhio per occhio» della legge del taglione, si può condurre anche contro i non combattenti compresi i bambini per cui sotto i bombardamenti di Gaza muoiono quattro persone innocenti per ogni capo di Hamas eliminato. E spesso anche quando si parla di pace si vuole «ottenere la pace», non «fare la pace». E nel primo caso anche la pace si cerca ancora con la guerra, mentre nel secondo la pace si costruisce con il dialogo, la comprensione, il riconoscimento dell’altro e la condivisione anche delle sue ragioni.
E tuttavia anche queste considerazioni, pur se legittime sul piano teorico, possono essere molto pericolose nella realtà perché possono indurre alla tentazione peggiore che è quella del fatalismo di chi pensa di lasciare gli uni e gli altri a «cuocere nel loro brodo». Oltre tutto quando si guarda solo a questo aspetto della pace ottenuta attraverso la vittoria e la pacificazione imposta con la paura si dimentica che negli ultimi venti anni si è sviluppata anche all’interno del conflitto arabo-israeliano , seppure in ritardo e seppure in misura terribilmente insufficiente rispetto alla bisogna, la cultura e la pratica della non violenza: giovani israeliani che si rifiutano di fare il servizio militare nei territori occupati, volontari che si mettono davanti ai bulldozer che demoliscono le case dei palestinesi, l’israeliano che si lega agli olivi dei palestinesi perché il proprio esercito non li abbatta, i cinquecento genitori palestinesi e israeliani di ragazzi morti in guerra che si mettono insieme nel Circolo dei Parenti per cercare la pace. Episodi di cui quasi mai si parla perché, come si sa, non solo le «cose buone», ma perfino le «cose belle» non fanno notizia.
Ma nella logica della guerra oggi soffocante non appare praticabile nemmeno una delle soluzioni parziali che potrebbero fare della striscia di Gaza qualcosa di diverso da quella grande prigione a cielo aperto affollata come un carcere italiano che di fatto è. Netanyahu non accetterà di aprire i valichi con l’esterno e di allargare le acque territoriali della Striscia tirando in ballo le armi che attraverso questi varchi possono arrivare dall’Iran. Né accetterà di ridare gli stipendi ai quarantamila funzionari di Gaza insinuando che metà di essi sono in realtà dei guerriglieri. D’altro lato il premier israeliano non ha mai ammesso esplicitamente la possibilità di uno stato palestinese e di fatto ne riduce ogni giorno la fattibilità e la credibilità con la costruzione dei muri e delle colonie ebraiche nei territori occupati. E tuttavia, anche senza una condizione, un risultato o un compromesso, è urgente far cessare subito una guerra in un territorio che per l’estremo addensamento della popolazione e il miscuglio voluto di guerriglieri e civili si presenta di fatto come una sorta di bombardamento di famiglie in scatola. Il basta agli eccidi, ai funerali dei caduti avvolti nella bandiera di Hamas, alla proclamazione quotidiana e collettiva di nuovi «martiri», servirà almeno a rallentare la marea di odio cresciuto sul lutto. Questo sì profitta davvero ad Hamas e mette sempre più ai margini un certo Abu Mazen, fresco della sua promessa di pace fatta poche settimane fa al Papa, e che in teoria dovrebbe essere il capo dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina.