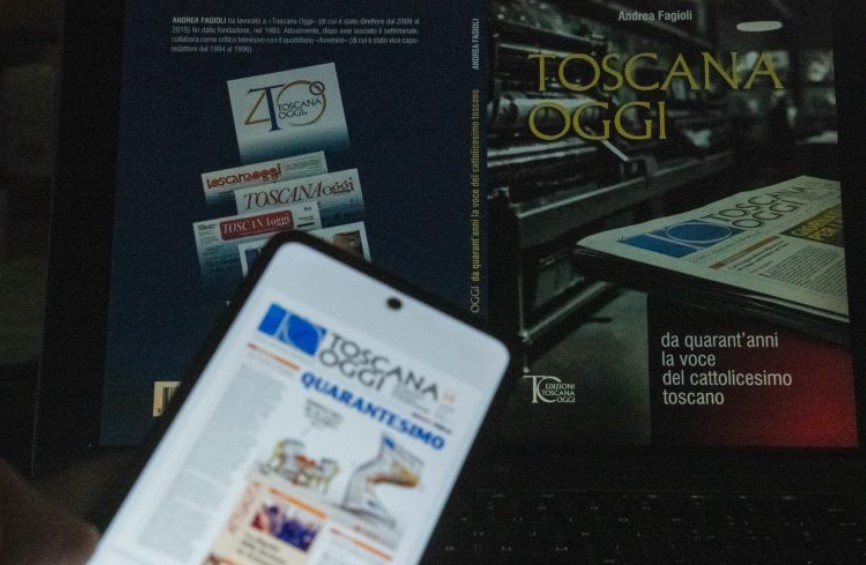Opinioni & Commenti
Gli scandali sugli appalti pubblici sono figli delle norme varate negli anni ’90
Le ferite degli ultimi tempi in fatto di «lavori pubblici» (di cui l’Expo è, in questo momento, l’evento più emergente) non possono non indurre ad alcune riflessioni generali. Con l’esercizio dell’umiltà, potremmo provare a ripartire proprio dalla prima legge dei lavori pubblici che, come «Firenze capitale», compie quest’anno 150 anni. La legge n. 2248 fu votata nel 1865 dal parlamento del regno d’Italia ed ebbe il suo «regolamento» trent’anni dopo, col Decreto Legge n. 350 del 1895. Con quell’ordinamento legislativo il nostro Paese traversò le ricostruzioni di due dopoguerra, accompagnandolo a traguardi apprezzabili e di tutto rispetto. Con quella legge il Piano Fanfani dette case ai meno fortunati, rispondendo a una domanda primaria del Paese e ridisegnando una ragionevole quiete del mercato dell’edilizia sociale. Con quell’ordinamento si realizzarono grandi infrastrutture, si sistemò buona parte della rete ferroviaria, si realizzarono nuovi quartieri (con la legge n. 167 del 1961). Nel contempo si crearono le condizioni affinché i comuni potessero avere dei Piani regolatori a guidare i nuovi assetti che i mutamenti demografici, migratori, produttivi, postulavano sul territorio, con nuova e più fluida mobilità. Si crearono anche nuovi aeroporti per fare dell’Italia un Paese rispettato che riuscì a collocarsi fra i sette paesi più industrializzati del mondo (privilegio oggi ereditato e sempre più a forte rischio). Incredibile! Tutto questo con quella legge del 1865 e il regolamento del 1895.
C’è dunque doverosamente da chiedersi su che cosa riposasse l’efficacia e l’efficienza di quell’assetto legislativo. C’erano forse due cose tanto semplici quanto perentorie: il fatto che, comunque, il costo dell’opera pubblica non potesse superare – quali che fossero le eventuali «perizie suppletive» – il quinto del costo stimato e contrattualizzato dell’opera (definito il «sesto/quinto»); il fatto che, indipendentemente dalle modalità di gara per l’aggiudicazione di un appalto, si conveniva che le offerte di ribasso che avessero superato il 25% dell’importo di gara sarebbero state cestinate in quanto «offerte anomale». Ciò nel ragionevole presupposto che nessuno lavora per rimetterci, rinunciando all’utile d’impresa. C’era poi un utile corollario che regolava i cosiddetti «sub-appalti»: la quantità di lavori specialistici (elettrici, idraulici, meccanici, per esempio) che dovevano essere contenuti entro aliquote assai piccole rispetto all’importo generale delle opere, e quindi le imprese dovevano essere realmente attrezzate ad affrontare i lavori in gara.
Tutto ciò fino ai primi anni Novanta del secolo scorso. Già perché nell’ultimo quarto di secolo si sono sistematicamente cancellate codeste precondizioni con una nuova incomprensibile ratio che ha fatto perdere persino la fisionomia dell’impresa. Si pensi che nel raptus degli anni Novanta (il decennio delle prime irreversibili anomalie) furono cancellate le sezioni specialistiche dall’Albo nazionale dei costruttori; così che, chi fino all’anno prima aveva prodotto rubinetterie poteva presentarsi ad una gara per strutture in cemento armato! Successivamente, il richiamo alla perentorietà del «sesto/quinto» fu silenziosamente accantonato (liberando i lavori a perizie suppletive senza limiti); infine, il colpo di grazia della cancellazione del concetto di «offerta anomala» e l’irresponsabile introduzione dell’offerta al «maggior ribasso»: da cui offerte aggiudicate spesso col 50% e più di ribasso. Da quel momento il «cantiere pubblico» finì di esser condotto dai tecnici, per esser consegnato agli studi legali, particolarmente preparati nel formulare «riserve» fin dal primo momento della consegna dei lavori. Ottenendo così due esilaranti risultati: fare del cantiere edilizio un campo di battaglia legale fra appaltatore e stazione appaltante (e direzione dei lavori) e rincorrere e provocare ogni pretesto per recuperare quell’anomalo 50% con cui si era vinta la gara. Così il gioco (il massacro) è fatto; ed è stato fatto dagli anni ’90 fino all’anno scorso a suon di provvedimenti di legge in parlamento e di decreti nel relativo ministero. A ciò va aggiunto il dilagare di competenze e adempimenti di enti i più diversi, assolutamente fuori controllo e spesso in conflitto fra loro, sempre più centrifughi rispetto a quella «unicità» di condotta che l’opera pubblica esige. Ed ancora il fatto che per le «grandi opere» si mette a punto una legge ad hoc, la «legge obbiettivo», con la quale si semplificano o si omettono alcuni passaggi di esami istituzionali.
E allora chiediamoci: si può riparare a questa deriva anomala e spesso irresponsabile che caratterizza questo scenario operativo ? Forse siamo ancora in tempo, purché si esprima una volontà politica e una competenza tecnica e giuridica all’altezza del problema.
In questo quadro, fragile e non facilmente gestibile (fino a quando non si correggeranno almeno le anomalie sopra accennate) vediamo, sinteticamente, gli impegni che attendono la Toscana e l’area fiorentina in particolare.
A cominciare dalla «nuova pista» del Vespucci che comporterà non pochi interventi indotti «infrastrutturali», come ad esempio una nuova aerostazione (quella attuale è stata finita da poco), non pochi lavori di riassetto idraulico, demolizioni e ricollocazione della torre di controllo, di hangar ed altro; di cui non conosciamo ancora alcun progetto esecutivo; del resto, siamo ancora in attesa di esser rassicurati – cosa non facile – dell’impatto della nuova pista col delicatissimo centro storico di Firenze e i suoi monumenti.
Il nuovo Stadio di Firenze continua ad esser portato in qua e in là, su rotelle, dall’area di Castello all’area Mercafir, tutto ciò adottando eventuali pesanti «varianti» al Piano strutturale della città.
Il «sottoattraversamento» TAV, resta di destini incerti, anche per il perdurare di inchieste e di proteste che l’hanno accompagnato, nonostante il «Piano integrato della mobilità urbana» di Firenze fosse stato presentato fin dalla giunta Primicerio, che avviò la nuova rete tramviaria.
Permangono opere «interrotte» come le testate del Viadotto di Rovezzano e dell’Indiano con penalizzanti condizioni della viabilità. Viabilità a cui non si dà risposta per l’uscita dell’autostrada Firenze-Mare, con le code ormai croniche per l’intera tratta Prato-Firenze. Nè si coglie la necessità di un raddoppio del Ponte dell’Indiano o di un nuovo ponte che semplifichi l’uscita a Peretola con una preuscita dall’autostrada per l’area di Scandicci e le Signe. E che dire dei «compendi monumentali» dismessi, da anni senza destino? Insomma, c’è quasi l’impressione che non si studi, non si analizzi più la città come organismo complesso. E non studiandola non la si capisce così che è più facile è commettere errori. La città è un organismo vivente che, come un corpo umano, va indagato, capito, curato: la tanto invocata «qualità della vita», tanto richiamata nei decenni passati, sembra davvero esser stata dimenticata.