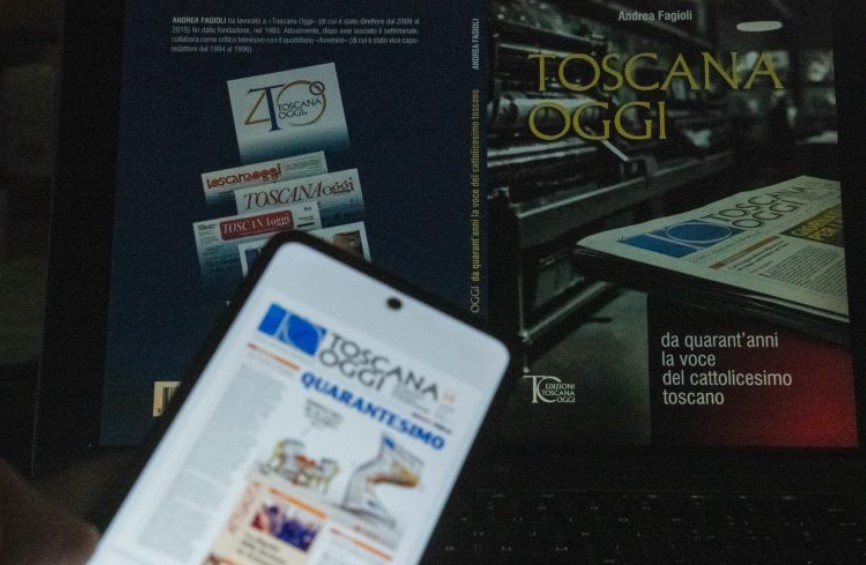Vita Chiesa
A scuola di preghiera/2: Corpo e anima pregano insieme

Questo dualismo, che nel corso dei secoli ha assunto molteplici forme, è completamente estraneo all’antropologia ebraica e cristiana. Non si può negare che la tradizione spirituale e teologica cristiana sia stata attratta, e in certa misura lo sia ancora, dal fascino della prospettiva platonica, e abbia insegnato che il corpo è un peso che impedisce all’anima di salire al cielo, ma oggi si può affermare con maggiore serenità ed esattezza che l’antagonismo tra spirito e materia, tra corpo e anima non appartiene alla Rivelazione. Corpo e anima sono due dimensioni che costituiscono l’uomo nella sua unità, per cui l’uomo biblico può dire che «è un corpo» e non semplicemente che «ha un corpo»; egli non è solo spirito né solo corpo, ma è uno «spirito incarnato».
Questa nuova consapevolezza circa l’identità dell’uomo, la quale meriterebbe un approfondimento maggiore di quello che è possibile in questa sede, ha delle ricadute significative nella spiritualità cristiana. La preghiera è una forma alta di dialogo, la cui iniziativa è di Dio che si rivela all’uomo e parla a lui come ad un amico (cfr. DV1), e a cui l’uomo partecipa nella sua interezza di anima e di corpo, così da poter dire come il salmista: «Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente» (84,3).
Il contatto con altri corpi, più delle parole, esprime la realtà della Chiesa che nella celebrazione eucaristica si rivela, quella di essere l’unico corpo di Cristo formato da molte membra (cfr. SC 2). Ma perché questo avvenga occorre accettare non solo il proprio corpo, ma anche quello degli altri. E questo non avviene sempre, perché la presenza dell’altro è molte volte avvertita non come dono, ma come un impedimento alle nostre esigenze.
Sento spesso dire: «la presenza degli altri mi disturba, preferisco pregare da solo», oppure quante volte sentiamo di preti che non tollerano la presenza dei bambini perché «disturbano» la preghiera degli adulti.
Infine, e soprattutto, attraverso il corpo facciamo esperienza della presenza di Cristo risorto: attraverso l’udito accogliamo la sua Parola, con il gusto abbiamo contatto con il suo Corpo, con la vista partecipiamo alla ritualità liturgica nel suo insieme. Pensiamo però quanto queste esperienze vengono a volte sacrificate da una lettura inespressiva e frettolosa, da una ritualità o troppo ridondante o completamente trascurata, e il gusto reso insignificante da un’ostia che – come diceva un mio vecchio insegnante -, ci vuole più fede a credere che sia pane che corpo di Cristo. Per non dire di quanto altri sensi siano sempre meno impiegati. Si pensi, ad esempio, all’olfatto: un tempo il profumo dell’incenso che accompagnava le celebrazioni, era sufficiente a farci percepire coi sensi la presenza misteriosa di Dio.
Il corpo è anche strumento di comunicazione. Quando si parla di «comunicazione», e in modo particolare quando ci si riferisce a quella specifica modalità in cui essa si realizza che è il «dialogo», pensiamo quasi spontaneamente al linguaggio verbale. Quest’ultimo è certamente il mezzo espressivo più comune attraverso il quale vengono comunicati dei messaggi, ma se analizziamo più da vicino il fenomeno complesso della comunicazione, ci accorgiamo però che, oltre alle parole, nel dialogo facciamo un largo uso anche del corpo. Anzi, a ben vedere, quest’ultimo è a volte più comunicativo e diretto delle stesse parole, e ci permette di esprimere sentimenti e stati interiori altrimenti dicibili. Solo qualche esempio.
Quando proviamo una forte emozione e vogliamo comunicarla, spesso diciamo: «non ho parole per descrivere quello che provo». Eppure i nostri occhi e i fremiti del corpo riescono a comunicarla senza aggiunta di parole. Similmente, quando incontriamo una persona che soffre e vogliamo farle coraggio e manifestargli la nostra prossimità, sentiamo che le parole ci muoiono in gola, e allora è spesso sufficiente e più efficace un abbraccio o una carezza. Gli esempi potrebbero continuare all’infinito, perché la verità è che non esiste un dialogo interpersonale in cui non sia coinvolto il nostro corpo. Se questo è vero per il dialogo interpersonale, tanto più dovrebbe esserlo per la preghiera, che non è una semplice comunicazione di informazioni, ma una partecipazione di vissuti interiori.
Eppure facciamo ancora fatica a credere che i gesti del corpo siano essi stessi preghiera. Lo stare in piedi o seduti, l’alzare le braccia al cielo o distenderle per stringere la mano dell’altro, battersi il petto o congiungere i palmi delle mani, nella liturgia non sono gesti estrinseci e secondari, ma appartengono intimamente alla ritualità liturgica e sono autentica preghiera. Per questo è necessario continuamente rieducarci alla gestualità liturgica anche attraverso una attenta catechesi.
A questo proposito mi pare significativo e attuale quanto la Commissione Episcopale per la Liturgia scriveva oltre dieci anni fa: «Abituati a considerare la celebrazione come un susseguirsi di cerimonie prescritte, il vero senso dell’agire rituale nella Liturgia cristiana sfugge a molti ministri e fedeli, che spesso soffrono il disagio di una certa estraneità a tutto ciò che si svolge intorno all’altare. [ ] È necessario che i ministri conoscano il valore dei gesti che compiono e dei segni che pongono; che sappiano valorizzarli pienamente secondo le esigenze dell’assemblea e le peculiarità delle culture locali; che facciano risaltare la ricchezza di significato che tali riti rivestono per la vita e per la fede dell’assemblea, rifuggendo allo stesso tempo dalla prolissità verbosa e dalla frettolosa approssimazione, favorendo invece una totale disponibilità a ricevere la ricchezza del dono di Dio» (Nota pastorale Il rinnovamento liturgico in Italia, 2).
Come ci muoviamo durante la Messa
Si legge nell’introduzione al Messale romano: «L’atteggiamento comune del corpo, che tutti i partecipanti al rito sono invitati a prendere, è il segno della comunità e dell’unità dell’assemblea: esso esprime e favorisce l’intenzione e i sentimenti dell’animo dei partecipanti».
Il cammino è uno dei gesti più significativi. È metafora dell’esistenza umana che è avvertita e vissuta da ogni uomo come cammino. Per il credente il camminare evoca in particolare il «pellegrinaggio», ossia quel singolare itinerario che nasce dalla risposta ad un invito (Gn 12,1), ha come meta l’incontro con Dio (Sal 16,11) e ci rende solidali con l’intera comunità (1Cr 29,15). Questa ricchezza simbolica si esprime soprattutto nella processione d’ingresso e nel momento in cui si accosta alla mensa eucaristica. Nell’ingresso del celebrante è significato il cammino che ciascuno ha fatto, accogliendo l’invito di Gesù. La messa, idealmente, comincia prima del segno di croce, quando da soli, o meglio ancora con tutta la famiglia, si esce dalla propria casa, si lasciano le occupazioni della vita per andare in chiesa, per ascoltare la Parola del Signore e per riconoscerlo, come un giorno accadde ai viandanti di Emmaus, nel pane spezzato.
L’Assemblea è anch’essa un importante segno liturgico. Essa manifesta – secondo quanto si legge nel Vaticano II – «il mistero di Cristo e della genuina natura della Chiesa». Per questo motivo l’uniformità dei gesti, delle posizioni del corpo, delle risposte e del canto all’unisono, non sono segno di appiattimento, ma rafforzano il significato della convocazione liturgica che esprime la realtà della Chiesa: «Un cuor solo, un’anima sola» pur nella «multiforme varietà dei doni».
Lo stare in piedi è la posizione che distingue l’uomo dagli altri animali, ed è l’atteggiamento più proprio del cristiano. Esso, pur consapevole del proprio peccato, riconosce la propria dignità di Figlio di Dio. Inoltre, stando in piedi, esprime quella prontezza che è richiesta a coloro che attendono l’incontro con il loro Signore (Cfr. Lc 12,35).
Stare seduti in una posizione comoda distende i muscoli del corpo e per questo favorisce la concentrazione e predispone all’ascolto. Il modello autentico è Maria, la sorella di Marta, la quale, «sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola» (Lc 10,39).